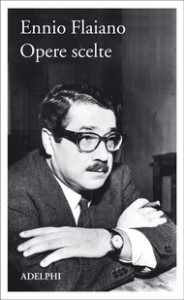Ennio Flaiano, lettera sull’Abruzzo a Pasquale Scarpitti
La Majella e il Gran Sasso sono le nostre basiliche
Caro Scarpitti,
adesso che mi ci fai pensare, mi domando anch’io che cosa ho conservato di abruzzese e debbo dire, ahimè, tutto; cioè l’orgoglio di esserlo, che mi riviene in gola quando meno me l’aspetto, per esempio quest’estate in Canada, parlando con alcuni abruzzesi della comunità di Montreal, gente straordinaria e fedele al ricordo della loro terra. Un orgoglio che ha le sue relative lacerazioni e ambivalenze di sentimenti verso tutto ciò che è Abruzzo.
Questo dovrebbe spiegarti il mio ritardo nel risponderti; e questo ti dice che non sono nato a Pescara per caso: c’era nato anche mio padre e mia madre veniva da Cappelle sul Tavo. I nonni paterni e materni anche essi del teramano, mia madre era fiera del paese di sua madre, Montepagano, che io ho visto una sola volta di sfuggita, in automobile, come facciamo noi, poveri viaggiatori d’oggi. Io ricordo una Pescara diversa, con cinquemila abitanti, al mare ci si andava con un tram a cavalli e le sere si passeggiava, incredibile!, per quella strada dove sono nato, il corso Manthonè, ora diventato un vicolo e allora persino elegante. Una Pescara piena di persone di famiglia, ci si conosceva tutti; una vera miniera di caratteri e di novelle che, se non ci fossero già quelle “della Pescara”, si potrebbe scavare. Ma l’ipoteca dannunziana è troppo forte, bisogna aspettare un altro poeta, e forse è già nato. Ciò che mi ha sempre colpito nella Pescara di allora era il buonumore delle persone, la loro gaiezza, il loro spirito. Tra i dati positivi della mia eredità abruzzese metto anche la tolleranza, la pietà cristiana (nelle campagne un uomo è ancora “nu cristiane”), – la benevolenza dell’umore, la semplicità, la franchezza nelle amicizie; e cioè quel sempre fermarmi alla prima impressione e non cambiare poi il giudizio sulle persone, accettandole come sono, riconoscendo i loro difetti come miei, anzi nei loro difetti i miei. Quel senso ospitale che è in noi, un po’ dovuto alla conformazione di una terra isolata, diciamo addirittura un’isola (nel Decamerone, Boccaccio cita una sola volta l’Abruzzo, come regione remota: “Gli è più lontano che Abruzzi”); un’isola schiacciata tra un mare esemplare e due montagne che non è possibile ignorare, monumentali e libere: se ci pensi bene, il Gran Sasso e la Majella sono le nostre basiliche, che si fronteggiano in un dialogo molto riuscito e complementare. Tra i dati negativi della stessa eredità: il sentimento che tutto è vanità, ed è quindi inutile portare a termine le cose, inutile far valere i propri diritti; e tutto ciò misto ad una disapprovazione muta, antica, a una sensualità disarmante, a un senso profondo della giustizia e della grazia, a un’accettazione della vita come preludio alla sola cosa certa, la morte: e da qui il disordine quotidiano, l’indecisione, la disattenzione a quello che ci succede attorno. Bisogna prenderci come siamo, gente rimasta di confine (a quale stato o nazione? O, forse, a quale tempo?) – con una sola morale: il Lavoro. E con le nostre Madonne vestite a lutto e le sette spade dei sette dolori ben confitte nel seno. Amico, dell’Abruzzo conosco poco, quel poco che ho nel sangue. Me ne andai all’età di cinque anni, vi tornai a sedici, a diciotto ero già trasferito a Roma, emigrante intellettuale, senza nemmeno la speranza di ritornarci. Ma le mie “estati” sono abruzzesi, e quindi conosco bene dell’Abruzzo il colore e il senso dell’estate, quando dai treni che riportavano a casa da lontani paesi, passavo il Tronto e rivedevo le prime case coloniche coi mazzi di granturco sui tetti, le spiagge libere ancora, i paesi affacciati su quei loro balconi naturali di colline, le più belle che io conosco. Poco so dell’Abruzzo interno e montano, appena le strade che portano a Roma. Dico sempre a me stesso che devo tornarci a “vederlo”. Non certo per scriverne, scrittori abruzzesi che possono dirci qualcosa dell’Abruzzo d’oggi non mancano, io indulgerei un po’ troppo nella memoria, non so più giudicare, capisci quello che voglio dire? O forse, chissà… questa lettera che mi hai cavato con la tua dolce pazienza non volevo scriverla, per un altro difetto abruzzese, il più grave, quello del pudore dei propri sentimenti. Non farmi aggiungere altro, statti bene e tanti saluti dal tuo,
Ennio Flaiano
tratto da “Discanto” di Pasquale Scarpitti, edito da Sarus